“Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente ed esistenziale.” Con queste parole, Yuji Iwasawa, presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, ha commentato la storica sentenza sugli obblighi giuridici vincolanti per i Paesi nel prevenire il riscaldamento globale. È la prima volta che un tribunale internazionale afferma con chiarezza che il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, ma anche legale, economica e finanziaria.
Questa svolta giuridica arriva mentre, a livello globale, cresce il numero di cause legali contro governi e aziende che non agiscono in modo adeguato contro la crisi climatica. E proprio queste cause, le cosiddette climate litigation, stanno diventando sempre più rilevanti per chi investe, anche in fondi comuni.
Il trend delle cause climatiche
Secondo il rapporto Global Trends in Climate Change Litigation 2025 Snapshot del Grantham Research Institute della London School of Economics, nel solo 2024 sono state avviate 226 nuove cause climatiche, portando il totale globale a quasi 3.000 casi in 60 Paesi.
Di queste, oltre l’80% sono classificate come “strategiche”: non si limitano a contestare un comportamento, ma mirano a influenzare la politica, la giurisprudenza e il dibattito pubblico. Il fenomeno è in rapida crescita anche nel Sud globale, dove il 56% dei procedimenti nel 2024 è stato avviato da enti pubblici, come procure o agenzie ambientali.
Le aziende sotto accusa
A fare scuola sono i casi come Lliuya contro RWE in Germania, dove una corte ha stabilito che un’azienda può essere ritenuta responsabile, in linea di principio, per i danni legati al cambiamento climatico. Oppure Milieudefensie contro Shell nei Paesi Bassi, che ha definito l’obbligo delle imprese di contribuire alla lotta climatica.
Anche in Italia potremmo essere all’inizio di una stagione di cause climatiche. La Corte di Cassazione ha stabilito, con un’ordinanza a luglio 2025, che si può fare causa a Eni e allo Stato italiano come azionista per i danni causati dal cambiamento climatico. La decisione è arrivata dopo la causa intentata al tribunale civile di Roma dalle organizzazioni ambientaliste Greenpeace Italia e ReCommon, e da dodici persone che ritenevano di essere state danneggiate dagli effetti del riscaldamento globale.
Le cause climatiche sono un rischio finanziario
Questa nuova ondata di contenziosi non è più un tema solo per avvocati o attivisti: è ormai materia per investitori. Le cause legali climatiche, infatti, influenzano la governance, la regolamentazione e soprattutto le decisioni finanziarie.
Nel 2024, il 20% dei casi ha riguardato direttamente aziende o i loro dirigenti. E non solo nel settore energia: sono sempre più coinvolti comparti come agricoltura, distribuzione alimentare, banche e fondi pensione. I procedimenti possono portare a sanzioni, obblighi di riduzione delle emissioni, o addirittura bloccare progetti già autorizzati.
Le cause che mirano alla responsabilità per le cosiddette emissioni Scope 3, ovvero quelle indirette lungo tutta la catena del valore, stanno costringendo le imprese a rivedere i propri piani industriali, con effetti concreti anche sulla redditività e sui rischi reputazionali.
Quale sarà l’impatto sulla governance
La crescita del contenzioso climatico sta trasformando anche la governance globale. Le corti supreme e costituzionali stanno progressivamente assumendo un ruolo chiave nel definire gli obblighi ambientali degli Stati e delle imprese. Tra il 2015 e il 2024, sono arrivati davanti ai giudici supremi ben 276 casi climatici, con una percentuale di successo per i ricorrenti superiore nel caso di aziende rispetto agli Stati.
Tuttavia, la crescente influenza delle cause climatiche incontra anche resistenze. In Europa si discute la revisione della Direttiva sulla Due Diligence Sostenibile, mentre negli Stati Uniti si moltiplicano i contenziosi contrari agli obblighi ESG. La polarizzazione politica, in particolare, sta alimentando anche cause non climate-aligned, che mirano a frenare o ostacolare politiche ambientali.
Nonostante queste forze contrarie, il quadro è chiaro: la pressione giudiziaria spinge verso una maggiore responsabilizzazione ambientale e sta diventando una leva indiretta di regolazione dei mercati.
IDEE DI INVESTIMENTO
Questo scenario richiede nuove chiavi di lettura per chi investe. In particolare:
- Le società di gestione sono chiamate a integrare i rischi legali e reputazionali legati al clima nei processi di selezione e monitoraggio dei titoli in portafoglio.
- Alcuni fondi già oggi escludono emittenti coinvolti in contenziosi climatici rilevanti o valutano con maggiore attenzione la trasparenza sulle strategie di decarbonizzazione.
- Cresce l’interesse verso fondi tematici che investono in imprese impegnate nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni.
Ma l’aspetto forse più rilevante è che i rischi da climate litigation sono ormai considerati “materiali”, ovvero in grado di incidere sui fondamentali economici di un’azienda. Questo vale non solo per i grandi inquinatori, ma anche per società di consulenza, distributori o operatori finanziari.
Per i risparmiatori che investono in fondi comuni, il contesto richiede un’attenzione nuova: non basta più valutare solo le performance finanziarie, ma serve anche analizzare l’esposizione ai rischi legali e reputazionali legati al clima.
Per investire nel lungo termine in fondi che abbiamo come focus la resilienza climatica Online SIM offre un percorso guidato attraverso i portafogli modello costruiti con diverse asset class e sviluppati sulla base di metodologie quantitative. Ogni portafoglio ha un grado di rischio differente e adotta strategie di investimento diverse puntando su settori, strumenti e Paesi.
I portafogli modello sono offerti dalle migliori società di gestione (UBS, Pictet Asset Management, Mc Advisory, Natixis Investment Managers, 4Timing Sim) comprese quelle specializzate in investimenti ESG e in fondi passivi Vanguard. Tra i portafogli in particolare uno è dedicato a combattere il cambiamento climatico. Scoprilo qui.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.





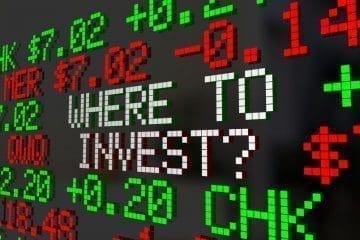



Nessun commento